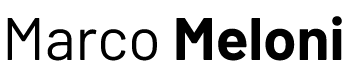Il Pd tra istinto di conservazione e vocazione riformista

Roma, 29 gennaio 2011. Qualche giorno fa Stefano Fassina, in una nota nella quale esprime le sue valutazioni sul discorso di Walter Veltroni al “Lingotto 2”, ha proposto una serie di argomenti stimolanti: dal confronto interno al Partito democratico ai più specifici dossier di politica economica e sociale di cui è responsabile in segreteria nazionale. Per concludere con una lettura dei fenomeni storici contemporanei e del profilo politico-culturale del partito. Nel documento che segue presento il contributo mio e di TrecentoSessanta a queste riflessioni.
Scarica il testo del documento.
Una premessa
Non è semplice conciliare il dovere di rappresentare la posizione di tutto il partito – specifico di chi ha un incarico nella segreteria nazionale – con il diritto di manifestare un proprio pensiero individuale. Per questo sarebbe forse preferibile farlo su temi non direttamente connessi a quelli dei quali si è ufficialmente responsabili. È anche vero, tuttavia, che la vasta materia economico-sociale è così centrale nell’agenda pubblica che è assai difficile prescinderne.
A tale difficoltà, dunque, mi pare possano principalmente imputarsi alcuni fraintendimenti ingenerati dall’intervento recente di Stefano Fassina a proposito del Lingotto 2. Tra questi, anzitutto, mi sembra contraddittorio il tentativo di ricondurre le posizioni di Veltroni a una convergenza della “minoranza” del Pd con i documenti approvati dalle Assemblee nazionali di Roma e Varese. In entrambe le circostanze, infatti, le decisioni sono state assunte all’unanimità o quasi: quindi, alla loro elaborazione hanno contribuito tutti, indipendentemente da una dialettica maggioranza-minoranza. E non è un caso, bensì una riprova del fatto che alle forzature siano preferibili sintesi condivise, che all’interno del partito su alcune questioni – dal diritto del lavoro alle relazioni industriali – permangano posizioni assai differenziate.
Il secondo fraintendimento nasce, a mio avviso, dalla contrapposizione rilevata da Fassina tra l'”impianto politico-culturale” espresso da Veltroni e la presunta linea ufficiale della maggioranza. Un giudizio che si discosta dalle opinioni espresse da Bersani e da altri dirigenti – Letta, Bindi, Franceschini, in primis -, i quali hanno invece osservato come, per spirito e contenuti, il Lingotto abbia segnato un passaggio importante verso l’unità del partito.
Più in generale, e al di là di queste note di metodo, un fatto è certo: il momento, per il Pd e per il Paese, è cruciale. L’Italia cerca una credibile forza di governo che succeda alla lunga e disastrosa agonia del berlusconismo. Il Partito democratico, per dimostrare di essere davvero all’altezza del compito, deve fare delle diverse impostazioni ideali la sua ricchezza. Al contrario, osservare le posizioni espresse dalle differenti anime del partito sotto la lente dell’antinomia maggioranza-minoranza rischia di inficiare sul nascere questo processo di sintesi e mescolanza.
Occorre, in altri termini, operare affinché l’attività delle aree interne al partito – le quali, su singoli temi, esprimono opinioni originali rispetto al mainstream prevalente – sia strumento di unità e dimostri così che la vulgata giornalistica sugli effetti perversi del “correntismo” in questo caso è fuori bersaglio. In realtà, un grande partito non può che essere il luogo del confronto e dell’unità tra idee, personalità e visioni elaborate in spazi aperti al dinamismo della società, come lo sono le associazioni, le fondazioni, i think tank. A patto naturalmente che non si decida di perdere per strada l’ambizione di essere “grandi” solo per il gusto di essere “divisi”.
Infine, leggendo l’intervento di Fassina, si potrebbe pensare che la “maggioranza” – chi ha votato a favore della relazione di Bersani nell’ultima Direzione, ad esempio – condivida l’impianto politico-culturale che egli evoca. Le cose non stanno affatto così, come cercherò di spiegare.
1. Mirafiori, una vicenda da prendere sul serio
Sulle politiche economiche e sociali – com’è noto – tra i democratici si registra una pluralità di posizioni. La questione va al di là del tema, pur centrale, del “diritto unico-contratto unico”, o delle valutazioni sulle singole proposte di Veltroni al Lingotto. Tanto per fare un esempio, trovo condivisibile – a prescindere da dettagli tecnici e quantificazioni precise – l’enfasi sulla riduzione del debito pubblico, mentre considero negativamente le ipotesi di patrimoniale.
Questa pluralità di orientamenti, negli ultimi mesi, ha comunque raggiunto il suo acme con la vicenda Fiat. Era inevitabile: come ci ha ricordato Lucia Annunziata sulla “Stampa”, Mirafiori è un luogo fisico e mentale che non si può aggirare. Per storia, capacità evocativa, ricadute concrete, la questione è diventata dirimente. E la posizione che si assume oggi al suo riguardo descrive l’idea che si ha del Paese, del futuro, dello sviluppo. Per questo dare una lettura condivisa della vicenda resta, a mio avviso, un obiettivo difficile ma ineludibile, specie per un grande partito che vuole essere interlocutore ed espressione di chi lavora e di chi produce.
Che fosse un obiettivo difficile l’abbiamo sperimentato quando, cercando di sottrarci alla logica manichea del referendum, e di enfatizzare il ruolo della politica – al quale il governo ha colpevolmente abdicato -, abbiamo adottato una linea che poteva essere così riassunta: “l’investimento è essenziale, ma non condividiamo il metodo e alcuni aspetti dell’accordo, né l’esclusione dalla rappresentanza”. Dinanzi a questo orientamento c’è stato chi – Sergio Cofferati e Matteo Orfini, ad esempio – ha fatto una scelta opposta, proclamando che avrebbe votato no e giudicando auspicabile tale risultato. Un risultato che pure avrebbe fatto svanire l’investimento e perdere migliaia di posti di lavoro: ma, è noto, l’affermazione di un punto di principio porta sempre con sé qualche conseguenza inevitabile. D’altro canto, c’è stato anche chi – nel solco della linea della segreteria – ha posto maggiore enfasi sull’opportunità di un successo del referendum e sulla portata della “sfida di Marchionne”. Tra questi coloro i quali, come Chiamparino e Fassino, meglio conoscono la vicenda torinese e bene sanno quanto quella fabbrica sia centrale per quella città (lo è per l’Italia tutta, in verità).
Sullo sfondo, sia tra i sostenitori del no, sia tra i più critici dell’accordo, vi era l’idea che i lavoratori si trovassero dinanzi non a una scelta, ma a un presunto ricatto cui reagire “con la schiena dritta” (implicito il giudizio sulla schiena di chi ha votato sì, come ha evidenziato efficacemente Pierluigi Battista sul “Corriere della Sera”). A scalare, posizioni orientate a intravedere nella vicenda l’emergere di un “capitalismo autoritario”, se non parafascista, con gli inevitabili “sindacati gialli” in veste di fiancheggiatori. Non so se quanti, nel nostro partito, sono tentati da simili suggestioni, abbiano chiaro che da qui a delegare la politica del Pd alla FIOM, riesumando la teoria secondo cui gli operai metalmeccanici sono l’incarnazione definitiva del lavoro, oltre che del destino della storia universale, il passo è brevissimo. Al contrario, secondo noi l’intera vicenda rappresenta ancora una buona occasione per ribadire con fermezza che il Pd deve, per sua stessa natura, dialogare e confrontarsi con tutti, ma poi esercitare la sua piena e assoluta autonomia, dal sindacato come dall’impresa e dalle altre parti sociali.
Di fronte a una vicenda di tale complessità, che sfida i nostri ordinari strumenti di analisi, non basta, dunque, mantenere staticamente una (legittima) pluralità di voci, perché il messaggio che ne scaturirebbe sarebbe incerto e ambiguo. Partiamo dalla realtà. Marchionne o non Marchionne, l’Italia ha una produttività del lavoro tra le più basse dell’Occidente e cresce meno dei suoi partner europei. In 10 anni da noi la produttività è aumentata del 3,6% (+25% in Gran Bretagna, +19% in Francia, +15% in Germania). Sulla crescita cumulata siamo il 179° Paese su 180 nel decennio 2000-2010. Per l’impatto delle regole sugli investimenti siamo al 118° posto su 139 Paesi. Questi sono problemi ineludibili. Senza crescere non possiamo vincere le diseguaglianze, rimodellare il welfare, colmare il divario tra chi ha un posto fisso e chi è precario, agire concretamente per l’occupazione giovanile (ad esempio, con gli sgravi fiscali del “contratto d’avvenire” proposto da Enrico Letta).
Superamento delle disuguaglianze, diritti e competitività non possono andare che di pari passo. “Senza gli utili, non c’è redistribuzione”, dice Marchionne. Lo interpretiamo come un richiamo al suo mestiere, visto che il costo del lavoro, come sappiamo, incide sui conti FIAT appena per il 7%. E anche come un richiamo ai fatti: la redistribuzione (problema drammatico per un Paese afflitto da disuguaglianze e fratture non solo territoriali) non passa certo dalla decrescita, come qualcuno vorrebbe raccontarci. La realtà di Torino è un’altra: quello di Mirafiori non è stato un ricatto. È stato un accordo sottoscritto da sindacati e votato dalla maggioranza dei lavoratori. L’evoluzione delle relazioni industriali è auspicabile, a patto che porti a più profitti, reale partecipazione, redistribuzione, investimenti in ricerca e supporti di welfare.
La sfida Fiat è, per questo, un’opportunità per il Paese, che non può permettersi di vivere ancora sull’assistenzialismo, ma che deve fondarsi sempre di più su una realtà produttiva in grado di espandersi e raggiungere mercati globali. Allo stesso tempo, sono essenziali le regole. I costi economici e sociali insostenibili dell’illegalità e della corruzione e l’esiguità degli investimenti esteri, legata fortemente all’incertezza del diritto e all’inefficienza della macchina amministrativa, configurano una vera e propria emergenza per l’Italia.
Usare questa vicenda per far riemergere la retorica del conflitto tra capitale e lavoro e magari far risorgere, sotto mentite spoglie, ideologie sulle quali la storia ha già emesso il suo verdetto, dichiarandone l’inesorabile sconfitta, è un errore fatale. E l’idea che il lavoro debba essere al centro della democrazia, come prevede la Costituzione, deve confrontarsi con la realtà dei lavoratori di oggi – che sono soprattutto precari, partite IVA, stagisti (di cui si dovrebbe parlare di più) – e con l’enorme ingiustizia di un welfare duale, fondato sul maschio lavoratore a tempo indeterminato, che abbandona a se stessi i non occupati, le donne, i giovani. Su questi punti la distanza tra le posizioni di un partito moderno e riformista e quelle assunte, nel contenuto e nella sostanza, dalle forze politiche e sindacali della sinistra radicale è nettissima, e non può essere sottaciuta. Mi permetto di rilevare che la partecipazione agli scioperi della FIOM di questi giorni, da parte di chi dovrebbe rappresentare la posizione di tutto il partito, non rende affatto chiara questa distanza e non fa che aggiungere confusione a confusione.
Dobbiamo aprirci alla realtà del mondo: gli aspetti immateriali sono parte integrante dell’economia. Su questo terreno – a partire dagli investimenti in conoscenza e innovazione – l’Italia appare sempre più indietro, così come sull’incidenza dei servizi sull’economia, spesso richiamata da Roger Abravanel. Anche le questioni fondamentali dell’economia dell’innovazione vanno affrontate assieme alle imprese straniere, la cui presenza è una ricchezza, soprattutto se accompagnata da un investimento sull’università e la ricerca che possa generare un ecosistema virtuoso per tutto il ciclo economico.
Per queste ragioni dobbiamo essere in grado di considerare la situazione complessiva dell’Italia, con un responsabile principio di realtà. Mentre gli altri Paesi si sono attrezzati per affrontare la crisi, il governo prima l’ha negata, e adesso osserva un paesaggio occupazionale sconfortante (non certo solo per gli operai, basti pensare ai numeri della disoccupazione giovanile), senza agire in alcun modo, a parte la consueta, grottesca, ricerca di capri espiatori. Con i tagli della Gelmini dire che “dobbiamo essere come i tedeschi” non ha alcun senso: quel sistema si basa sulla creazione delle condizioni istituzionali e strutturali per lo sviluppo, anche attraverso gli investimenti in ricerca e innovazione, come spiegato Gianmarco Ottaviano su lavoce.info. Per ripartire, l’Italia deve, piuttosto, riscoprire l’attenzione per il capitale umano e per le politiche dell’istruzione che già animava, agli albori degli anni ’90, le analisi di Romano Prodi sul “capitalismo ben temperato”. Una riflessione che appare quanto mai attuale in un Paese in cui, come ha ben argomentato Marco Simoni, i giovani non sono affatto “disoccupati per colpa loro”.
2. Regole e diritti, equità e mobilità: il riformismo che serve all’Italia
La connessione tra le vicende economiche e sociali e la visione storico-culturale è, naturalmente, molto forte. È su questa interrelazione che si gioca la partita più complessa e, al contempo, più decisiva per il futuro del Pd e per la modernizzazione dell’Italia. Fassina non solo fa derivare dai fallimenti del mercato senza regole una condanna senza appello del riformismo liberale e sociale che è alla base del pensiero “democratico”, ma stavolta va oltre, contestando apertamente la cultura liberal-democratica. La quale, fino a prova contraria, è quella dello Stato di diritto e di “mercato, concorrenza e regole”.
Lo affermiamo con la massima chiarezza: questa non è una visione condivisibile e vogliamo escludere che essa possa essere propria della “maggioranza” del Pd. Non so quali tra le alternative – operaismo, teocrazie, capitalismo con caratteristiche cinesi – possano sembrare praticabili nel nostro Paese, e la realtà dello stesso pensiero economico (si pensi anzitutto ad Adam Smith, nell’autorevole interpretazione di Emma Rothschild, per non parlare di quella del premier cinese Wen Jiabao) sfugge alle facili semplificazioni. In ogni caso, non pensiamo che sfidarci a colpi di citazioni sia così utile per tornare a parlare al Paese. Certo, quando si analizza la dottrina sociale della Chiesa, sarebbe necessario un maggiore rigore argomentativo – come ci ricorda Stefano Ceccanti – soprattutto per affrontare i temi della sussidiarietà e del ruolo dei corpi intermedi, sempre più centrali in una società “poliarchica” dove lo Stato e il “Partito” non possono pretendere di esprimere un pensiero onnicomprensivo.
Sappiamo tutti che, per ridisegnare le regole del mercato e per estenderne l’ambito alla dimensione globale del sistema economico e finanziario, servono più Europa e più cooperazione internazionale. Un’Europa con una guida politica eletta direttamente dai cittadini, come in Italia diciamo da una decina d’anni, ben prima che ne scrivesse il PSE. Ma da qui a dire che “la politica” – una politica sulla cui crisi dobbiamo interrogarci con umiltà – debba incidere direttamente sulle scelte degli individui e degli attori economici ce ne passa, perché ciò lederebbe gli stessi spazi di libertà di un’etica della relazione, incentrata sul rispetto delle persone e sulla loro libera interazione nella comunità. In altri termini, regole e mercato sono le condizioni per la piena libertà delle persone, singole e associate, e perché esse possano esprimere appieno la propria iniziativa, in campo economico e sociale. Lo Stato, il pubblico, non deve interferire con questa libertà, ma porre pari opportunità di partenza e regolare le politiche pubbliche, affidandone la gestione al rapporto tra pubblico e privato secondo il principio di sussidiarietà.
Tornando all’agenda interna, forse è vero che dopo la disarticolazione del primo Ulivo vi fu un “eccesso liberista”, in particolare nelle forze della sinistra, legato anche al vuoto ideologico all’indomani dello shock geopolitico dell”89. Eppure, oggi sbaglia chi sostiene che la conversione piena al capitalismo e al libero mercato fu allora precipitosa, se non addirittura inopportuna. Così come semplicistico mi sembra concludere, con un giudizio sommario sulla morte dello spirito d’impresa come motore di sviluppo e opportunità, un ragionamento che pure, sulla carta, ha una sua coerenza logica: il reato sarebbe la crisi, il movente l’avidità del mercato, il condannato il capitalismo. Come se tutto il resto – l’assenza di regole, gli errori delle classi dirigenti, le varietà del capitalismo, la portata sconvolgente della rivoluzione tecnologica in atto, la trasformazione a 360 gradi del quadro geoeconomico, con l’emergere di centinaia di milioni di persone dagli inferi della miseria e del sottosviluppo – potesse rappresentare null’altro che un complemento d’arredo, un ininfluente elemento di contesto della storia politica e sociale degli ultimi vent’anni.
Su questa falsariga tornano in auge interrogativi superati dalla storia stessa, come quello su una presunta dicotomia tra Stato e mercato. Al contrario, dovremmo chiederci quale Stato vogliamo costruire per le generazioni future, come garantire le regole affinché i cittadini esprimano la propria iniziativa liberamente, quali politiche pubbliche attivare per fare in modo che i nostri figli possano considerare l’Italia un Paese in cui davvero valga la pena di vivere. Tra il pubblico che torna a svolgere il proprio ruolo e la riproposizione del conflitto tra capitale e lavoro c’è un fossato incolmabile, soprattutto in un Paese che ha bisogno non di un deserto ma di imprese per creare lavoro, non di assistenzialismo ma di una riduzione e di una riqualificazione rigorosa della spesa pubblica. Che l’Italia non disponga delle risorse della Cina per fare investimenti pubblici e generare occupazione è chiaro anche a un bambino. Ammetterlo, richiamandosi al rigore e alla qualità della spesa, non è certo “subalternità a Tremonti”, ma semplice senso della realtà.
La crisi non si risolve con “più Stato e meno mercato”, dunque, ma con il superamento dei mille blocchi alla concorrenza e con un settore pubblico efficiente, che liberi risorse anzitutto per le politiche redistributive e quelle per il futuro (conoscenza e mobilità sociale, famiglia e natalità, imprenditorialità, innovazione e internazionalizzazione). Con quelle liberalizzazioni e quelle liberazioni da “lacci e lacciuoli” – sì, proprio quelli – che in Italia negli anni ‘80 e ‘90 non ha fatto quasi nessuno (ad eccezione di Prodi e Bersani, i quali non hanno poi potuto completare, loro malgrado, il percorso avviato). Questo è il vero coraggio riformista con cui si costruisce una società più competitiva e più coesa, che abbia la forza di disfarsi del fardello delle corporazioni, di parlare a tutti i lavoratori (dipendenti e autonomi, professionisti, imprenditori e artigiani) e di difenderne realmente i diritti, di fondare la mobilità (sociale, generazionale, territoriale) sulle opportunità e sulla meritocrazia. Questa è la giustizia sociale, queste sono le vie per porre rimedio alle diseguaglianze. L’alternativa è una decrescita – culturale, ancor prima che economica – che è sempre “infelice”, soprattutto per i giovani cui vengono servite due polpette avvelenate: un enorme debito da pagare e nessuna politica per lo sviluppo (e quindi per il lavoro).
Fassina scrive: “Celebrare la modernità economicistica di Marchionne implica una prospettiva di rassegnazione pragmatica e di subalternità politica al lavoro. Invece, la centralità politica ed economica del lavoro è l’eredità del ‘900 da portare nel riformismo del XXI secolo”. Vi è una distinzione teoretica tra chi pensa che il centro dell’azione politica debba essere la persona (da cui derivano creatività, lavoro, impresa) e tra chi pensa che, invece, la stessa persona sia un predicato del soggetto lavoratore. Ma il punto dirimente, ancora una volta, è l’aderenza alla realtà, su cui dobbiamo giudicare chi pensa che le parole “lotta” e “lavoro”, agitate come armi contundenti, siano magicamente in grado di creare, da sole, l’agognata occupazione, il benessere, la giustizia e l’uguaglianza, verso cui tendevano le democrazie europee del secondo dopoguerra.
Anche nell’attuale “sguardo di Medusa” abbiamo il dovere di ricordare che, senza la Fiat, a detta di tutti, a Pomigliano migliaia di persone sarebbero costrette a votarsi a datori di lavoro molto meno rispettosi dei loro diritti e molto meno trasparenti, presumibilmente legati alla capillare influenza della camorra, e che, nell’attesa dell’azienda estera perfetta per Pomigliano o Mirafiori, assisteremmo a un dramma sociale, oltreché al funerale del futuro industriale dell’Italia.
Forse gli operai notano questa sfasatura tra le parole e i fatti, visto che votano per il Pd molto meno di quanto ci aspetteremmo. Ad ogni modo, noi sosteniamo la centralità politica ed economica della persona, pensiamo a superare il dualismo del mercato del lavoro e pensiamo, soprattutto, a chi un lavoro non ce l’ha. Quanti si ostinano a vedere nell’operaio-massa un soggetto collettivo cui delegare il destino di una storia inevitabilmente conflittuale – e magari auspicano, con la crisi e la globalizzazione, l’avvento di un nuovo internazionalismo operaio – antepongono il tentativo di riproporre uno schema ideologico inattuale alle giuste istanze di miglioramento delle condizioni di vita dei lavoratori. Il mondo – sinistra europea compresa – guarda avanti. Dobbiamo farlo anche noi. Per questo la cosa migliore su cui concentrarci ora per il bene dell’Italia è interpretare la realtà, assumerci in pieno le nostre responsabilità, convincere la maggioranza degli elettori a votarci per tornare alla guida del Paese.
3. Oltre la socialdemocrazia, il Partito democratico
Siamo, in conclusione, a uno snodo decisivo: in gioco ci sono l’essenza del Pd e il suo futuro. Da qualche mese sembra fare capolino l’idea che l’opzione migliore per la sinistra sia costruire un solido partito socialdemocratico, anzi un partito di “sinistra”, senza trattini e senza ambiguità. Il Pd è nato con una missione diversa: essere una forza di centrosinistra con una prospettiva più ampia di quella di una socialdemocrazia in difficoltà in tutta Europa e che mai, da sola, nell’Italia repubblicana è riuscita a trovare i numeri, le idee e le persone giuste per farsi forza di governo. Di più: pensiamo che per governare il Paese sia necessario concorrere al centro dell’offerta politica, e che sia indispensabile lavorare per questo. Il centro non è una caricatura: è lo spazio politico in cui risiedono le necessità e i bisogni della maggioranza degli italiani e, in particolare, della gran parte degli elettori moderati. Che non sono un’orda ignorante, come alcune irrispettose analisi continuano a sostenere, neppure quando – anche a causa di un nostro atteggiamento ostinatamente snob – si rifugiano nell’abbraccio del populismo berlusconiano. Quanti tra loro percepiscono che l’Italia ha bisogno di uno scatto di cambiamento e modernizzazione meritano di trovare un’offerta politica adeguata. Dunque, il Pd deve sapersi rivolgere, insieme, all’Italia progressista e a quella moderata, perché, per affrontare il profondo processo riformatore di cui il Paese ha bisogno, sono necessarie ampie alleanze politiche e sociali. È ancora qui il nodo da sciogliere. E va sciolto con scelte nette e proposte concrete.
Questo è il terreno privilegiato a partire dal quale costruire le possibili alleanze. E il dovere del Pd è chiarire una volta per tutte, con le forze alla sua sinistra, le rispettive posizioni su temi centrali: l’Europa, le missioni internazionali, l’ambiente e l’energia, le relazioni industriali, i rapporti tra Stato e mercato, e, dunque, la concorrenza e le liberalizzazioni. Il Pd è nato per parlare a tutto il Paese. Il Pd è un partito interclassista che presenta ai cittadini la visione di una società delle opportunità e delle garanzie sociali, del merito e dell’equità. Il Pd si fonda sulle intuizioni del miglior riformismo europeo e italiano per coniugare regole e diritti da un lato e rigore e doveri dall’altro. Se dimentichiamo tutto questo, il Pd non ha senso.
Leggiamo, invece, di una competizione suicida tutta schiacciata a sinistra, quasi che sovrapporre la nostra voce alle parole che descrivono – siano quelle incendiarie di Landini e di Cremaschi, oppure quelle più melliflue nei toni, ma analogamente populiste e antistoriche nella sostanza di Vendola – l’affermazione di un neoconservatorismo populista di sinistra, sia una scelta priva di conseguenze. Le conseguenze, invece, ci sono, e sono chiarissime: oltre alla perdita della nostra ispirazione fondativa, nessun consenso strappato ai partiti dell’ex centrodestra, praterie di voti alle forze centriste. Con le quali dovremmo allearci – se, come credo, condividiamo gli aspetti fondamentali del programma – ma da una posizione di forza. Non per rispolverare una presunta autosufficienza, ma per rivendicare la nostra preminenza, la capacità di mettere al centro l’intera comunità e la dedizione all’interesse generale e alla coesione dell'”Italia tutta intera”.
Guardare il Paese con gli occhiali della realtà e la passione della politica è sempre più difficile e sempre più necessario. Dobbiamo ripartire dalle radici del pensiero democratico italiano. Dal riformismo figlio del moderno cattolicesimo sociale di Romano Prodi e della cultura della sinistra moderata e liberale di Michele Salvati. Da una visione di governo, come quella di Nino Andreatta, fondata su un’Italia fatta di persone, di imprese, di associazioni, di regole, di diverse tipologie di lavoro, di possibilità economiche, e di quel rigore di bilancio che ha animato il “miracolo” dell’ingresso italiano in Europa. Dalla voglia di essere una forza del cambiamento, dell’avvenire. Di quel domani che, ci insegnava Aldo Moro, “non appartiene ai conservatori ed ai tiranni” (né ai populisti, aggiungeremmo oggi), ma “è degli innovatori attenti, seri, senza retorica”. La storia ci insegna che gli Stati non si reggono né sull’indignazione né sulla rassegnazione, ma sulla capacità di dare soluzioni ai problemi, governando. E che “in ogni situazione c’è sempre una riforma possibile”.
Forse ha ragione Fassina, e la sua provocazione è positiva: non dobbiamo più lasciare spazio a equivoci sulla nostra visione politica e culturale. Se è così, cogliamo questa occasione per discutere senza reticenze, in uno spirito unitario che comprenda tutte le esperienze e le culture che hanno dato vita al Pd, e che abbia anche l’obiettivo di riportare nella loro naturale collocazione le forze che in tutto il mondo sono nel centrosinistra – penso ai socialisti riformisti, soprattutto – e quelle di un cattolicesimo politico che sta rilanciando la propria vocazione all’impegno civile per far rialzare questo Paese umiliato e scosso. Serve uno sforzo collettivo di analisi, responsabilità e realismo. Se dovesse, invece, prevalere l’impostazione di chi intende superare la liberal-democrazia e riaprire una nuova fase di conflitto tra capitale e lavoro, sarebbe del tutto ovvia e legittima l’integrazione tra Pd e SEL, e la rifondazione di un nuovo soggetto di sinistra-sinistra. Sarebbe, è di tutta evidenza, la fine del Pd. Un errore drammatico soprattutto perché priverebbe l’Italia dell’opportunità che si riapra, dopo la felice ma troppo breve stagione del primo Ulivo, quel ciclo di riforme – queste sì, radicali – di cui essa ha un bisogno ormai vitale.